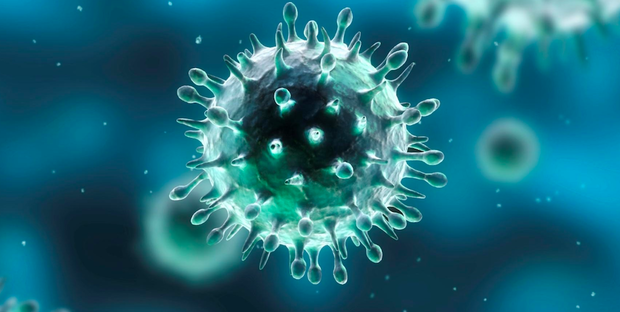Anniversario del 25 aprile: I professori che si opposero al Duce
Un grande gesto di coraggio e di autonomia intellettuale da ricordare nel giorno della Liberazione.
Anche questo 25 aprile, il secondo della pandemia, verrà celebrato un po’ in sordina.
Eppure la memoria della Liberazione resta densa di significato. Perché ci aiuta a esser consapevoli delle grandi conquiste democratiche e liberali di cui oggi godiamo.
Per esempio, nel settore dell’Università. Questo è il primo anno in cui l’Italia ha un dicastero a essa dedicato (Ministero dell’Università e della Ricerca), presieduto dalla Ministra Maria Cristina Messa. Ma com’era gestita l’Università durante il Regime?
Facciamo un passo indietro.
Novant’anni fa lo Stato Fascista diede una spinta in più alla realizzazione del suo disegno totalitarista.
Nel 1931 le Università divennero veri e propri strumenti di propaganda, mezzi di creazione del consenso e di lotta al pensiero dissenziente.
«I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi Istituti d’Istruzione Superiore» furono obbligati a giurare che avrebbero adempiuto a tutti i doveri accademici «col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista» e che non sarebbero mai appartenuti ad «associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri dell’ufficio», ossia con quelli posti dal Regime.
Chi non giura è rovinato: perde la cattedra, la liquidazione, la pensione, viene emarginato e tacciato d’essere antitaliano.
Fisici, matematici, ingegneri, architetti, filosofi, letterati, storici, giuristi, scienziati di ogni genere devono impegnarsi solennemente a non concepire idee, a non fare scoperte che in qualche modo contrastino con i principi e i fini della dittatura.
La stragran parte dei professori accettò l’imposizione. Molti per convinzione, altri perché preferirono la carriera alla coscienza.
Vi fu chi, «con la folta barba bianca bagnata dalle lacrime», confessò: «coprirò di vergogna tutta la mia opera di scrittore e di pensatore, ma non posso mettere sul lastrico i miei figlioli giovinetti» (Giuseppe Lombardo Radice). Chi cedette, portandosi dietro per tutta la vita un cruccio costante (Giuseppe Rensi) e chi si sottomise con un “firmo perché padre di famiglia!” (Francesco Lemmi).
Qualcuno, dopo quarant’anni, sentendosi ancora umiliato, ammise che la povertà lo aveva spaventato più della guerra (Arturo Carlo Jemolo). Un altro disse che non poteva lasciare, perché l’insegnamento era «il suo posto di combattimento», ma proseguì i suoi anni con «l’animo straziato» (Piero Calamandrei). Altri giurarono con riserva (espressa), scrivendo al Rettore che «in alcun modo avrebbero modificato l’indirizzo del proprio insegnamento» (Alessandro Levi e Tullio Levi-Civita).
Un critico letterario, disgustato, giurò con un gesto teatrale di spregio (ma giurò): la mano rivestita di un guanto per non contaminarsi con la firma; la penna gettata sul tavolo subito dopo, con calamaio rovesciato e schizzi d’inchiostro sul tavolo (Alfredo Galletti).
Uno sostenne addirittura che «il vero atto di coraggio consisteva nel giurare» (Tullio Ascarelli).
Ancora, vi fu chi non giurò, ma espresse il rifiuto senza guardare in faccia il Regime, trovandosi un commodus discessus (Vittorio Emanuele Orlando, già Presidente del Consiglio dopo il disastro di Caporetto, andò in pensione anticipatamente).
Palmiro Togliatti, guida storica comunista, considerò che restare in cattedra fosse «estremamente utile per il partito e per la causa dell’antifascismo». E i professori di sinistra giurarono.
Papa Pio XI disapprovò il giuramento; alla fine, però, lo consentì, ma con la riserva (interiore) di non contraddire i principi della Chiesa. E anche i docenti cattolici firmarono.
Gaetano Salvemini, esule già dal 1925, tuonò contro questa generale genuflessione: «Nessun professore di storia contemporanea, nessun professore di italiano, nessuno di coloro che in passato s’erano vantati di essere socialisti aveva sacrificato lo stipendio alle convinzioni così baldanzosamente esibite in tempi di bonaccia».
Ma, in questo campo d’erba comune e di giunchi spezzati, sbocciò qualche bel fiore.
Vito Volterra (fisica) non appena ricevette l’invito a presentarsi per il giuramento, lo respinse senza esitazione, non potendo «in coscienza» aderirvi.
Bartolo Nigrisoli (chirurgia), esortato a firmare dal Rettore, rispose: «Giuramento simile io non mi sento di farlo e non lo faccio».
Mario Carrara (antropologia criminale e medicina legale) scrisse al Ministro: «Abituato all’attribuire al giuramento la serietà dovuta, non ho sentito di potermi impegnare a dare intonazione, orientamento, finalità politiche alla mia attività didattica».
E con loro questi altri pochi professori coraggiosi: Edoardo Ruffini (storia del diritto), Giuseppe Antonio Borgese (estetica), Ernesto Buonaiuti (storia del cristianesimo), Aldo Capitini (segretario-economo della Normale di Pisa), Gaetano De Sanctis (storia antica), Antonio De Viti De Marco (scienza delle finanze), Floriano Del Secolo (lettere, italianistica), Giorgio Errera (chimica), Cesare Goretti (filosofia del diritto), Giorgio Levi Della Vida (lingue semitiche), Fabio Luzzatto (diritto civile), Piero Martinetti (filosofia), Errico Presutti (diritto amministrativo), Francesco Ruffini (diritto ecclesiastico), Lionello Venturi (storia dell’arte).
Uomini liberi che, in solitudine, attanagliati dal Regime, hanno saputo rinunciare a tutto per difendere la propria moralità e la propria coscienza.
In questo 25 aprile ricordiamo i loro nomi.